Dalle luci da discoteca per allenare i Cheetahs (da cui il soprannome DJ Rassie) ai momenti più duri, tra l’alcolismo del padre e la malattia di Wegener, fino ai due titoli mondiali conquistati con gli Springboks: le cicatrici e le vittorie di un personaggio unico
Francesco Palma
16 luglio - 16:58 - MILANO
Arrogante, geniale, sbruffone, istrionico, iracondo: gliene hanno dette di tutti i colori. A volte a ragione, a volte con la supponenza di conoscere chi si è solo costruito una maschera e fa vedere all’esterno solo ciò che vuole. Rassie Erasmus è questo e tanto altro ancora. A cominciare dal nome, visto che in realtà si chiama Johan, e “Rassie” non è scritto da nessuna parte: è un soprannome venuto dal nulla, forse perché suona semplicemente meglio. Una cosa è certa, e su questo sono d’accordo tutti, estimatori e detrattori, idolatri e odiatori: è un vincente, di quelli veri, di quelli che arrivano sempre prima, di quelli che hanno già capito tutto prima degli altri. Sugli aspetti controversi poi si può discutere, dalle continue polemiche verso gli arbitri che lo hanno portato a due lunghe squalifiche ad alcuni atteggiamenti magari eccessivamente spocchiosi (per ultimo, l’aver cominciato l’ultima partita con l’Italia commettendo volutamente un’infrazione per giocare una mischia, dove sapevano di essere più forti) fino a un utilizzo quantomeno “eccentrico” di Twitter che utilizzava per scrivere post provocatori contro World Rugby (celebre il "Quando l'ignoranza urla, l'intelligenza tace” scritto durante il processo disciplinare per il video di 62 minuti contro l’arbitro Nic Berry dopo il primo match tra Sudafrica e Lions) ma intanto col Sudafrica ha vinto due Mondiali, uno del 2019 da capo allenatore, uno nel 2023 da Director of Rugby, e ora è tornato ad allenare. Fosse per il Sudafrica lo terrebbero lì a vita, in qualsiasi ruolo voglia stare: lui però ancora deve decidere cosa fare dopo il prossimo Mondiale, nel 2027. Del resto, di decisioni forti ne ha sempre prese, come quando decise di mandare a quel paese mezza federazione sudafricana – era il periodo della corruzione, della politica dentro il rugby, delle quote nere imposte per ripulirsi l’immagine – per andare ad allenare in Irlanda, a Munster, portandosi dietro anche il fedelissimo Jacques Nienaber, con cui ha vinto i due titoli mondiali (nel 2019 era assistente e nel 2023 capo allenatore) fino a quando – dopo la clamorosa sconfitta del 2016 con l’Italia a Firenze, il punto più basso – non vennero in ginocchio a pregarlo di ritornare, di prendere in mano non solo la squadra ma tutto il movimento. Ha aspettato per un po’, poi nel 2018 – a un solo anno dal Mondiale – ha accettato. Ha lottato contro tutti, se n’è fregato della politica, dei giochi di potere: non gli hanno dato carta bianca, se l’è presa di forza. Ha preso in mano il peggior Sudafrica della storia e lo ha fatto diventare la squadra più forte del mondo, una delle più forti e vincenti della storia.
cresciuto (troppo) in fretta
—
Di Erasmus si conoscono i colpi di genio, le giocate che solo il suo Sudafrica è in grado di fare, le idee visionarie: tutto quello che lo ha portato ad alzare la coppa due volte. Ma dietro (e dentro) quel sorriso sempre sornione dei trionfi di Yokohama e Parigi c’è la storia di un ragazzo diventato uomo veramente troppo in fretta, quando a 14 anni doveva prendere la macchina, caricarci sopra suo padre – che soffriva di alcolismo – e portarlo in ospedale quando beveva troppo. O quando doveva nascondersi da lui perché girava in casa con un fucile, o quando doveva sopportare quella che per lui era la cosa peggiore: essere messo in discussione nel rugby. “Dove vuoi andare con quel collo sottile, non combinerai molto” gli diceva: “Questo mi faceva male 10 volte più del fatto che volesse spararmi” ricordava Erasmus. Forse proprio perché costretto a crescere in fretta, ha imparato a capire tutto prima degli altri, pur pagando un prezzo molto elevato, e non solo perché per tanto tempo ha fatto fatica – pur non cadendo mai nella dipendenza – a gestire il suo rapporto con l’alcol, dopo quello che aveva passato, ma c’è di più: pensarlo adesso sembra incredibile, ma Rassie Erasmus non si è mai sentito all’altezza. La prima volta in cui ha avuto davvero l’impressione di aver fatto qualcosa di importante è stata nel 2019, quando ha alzato la Coppa a Yokohama, dopo che il suo Sudafrica aveva sbaragliato l’Inghilterra nella prima delle due finali mondiali vinte. Anche perché – e lo ha rivelato solo anni dopo – quel Mondiale per lui è stato un inferno, e quell’inferno aveva un nome: malattia di Wegener, una patologia rara e pericolosa, un’infiammazione dei vasi sanguigni che finisce per ammalare tutto il corpo, dai reni alle vie respiratorie, fino alle articolazioni. Una malattia che debilita, logora, che va curata con farmaci pesanti. Come se non bastasse c’era un Mondiale da preparare, e a tutte le problematiche del caso si aggiungevano anche le voci assurde che correvano su di lui, perché le cure lo avevano estremamente gonfiato, e soprattutto non correva più in campo con i ragazzi, cosa che ha sempre amato fare. Dicevano che fosse ingrassato perché faceva festa, che bevesse troppo come quando era giovane, mentre la verità era tutt’altra: avrebbe voluto urlarlo al mondo, e tutti avrebbero smesso di rompergli le scatole, ma avrebbe rischiato di penalizzare la squadra, che doveva rimanere tranquilla e senza ulteriori tensioni, visto che ce n’erano già abbastanza. Erasmus si è caricato tutto sulle spalle: durante le partite seguiva alcuni spezzoni con il cellulare dal bagno e in costante contatto col resto dello staff, perché i suoi reni sovraccaricati lo costringevano ad andarci in continuazione. E alla fine ha vinto.
il "dj rassie" visionario
—
Che Erasmus fosse anni luce davanti a tutti se n’era già accorto Nick Mallett, allenatore del Sudafrica dal 1997 al 2000 (e poi anche dell’Italia dal 2008 al 2011), forse gli anni migliori del Rassie giocatore. Anzi, “giocatore” era riduttivo già all’epoca, considerando che girava per il ritiro del Sudafrica con computer e stampante (e non quelli di adesso, ma i mattoni giganti degli anni ’90) e andava dal c.t. a proporgli le sue idee per migliorare l’assetto tattico della squadra. Oggi le grandi nazionali hanno uno squadrone di video-analyst, lui lo faceva prima ancora che quel ruolo fosse inventato. E soprattutto, Mallett lo lasciava fare, ne apprezzava l’intelligenza e anche la capacità di proporre le sue idee senza mai risultare eccessivo, considerando che si trattava di un giocatore – per quanto carismatico – che andava dal suo allenatore per discutere di tattica. Appese le scarpe al chiodo e diventato ovviamente allenatore, poi, Erasmus ha proseguito sulla stessa strada, inventandosi cose che nessuno aveva mai pensato prima. Quando allenava i Cheetahs, in Sudafrica, fece montare delle luci da discoteca allo stadio, tanto da essere soprannominato “DJ Rassie”. Perché? Ogni strategia di gioco aveva un colore diverso. Erasmus e il suo staff avevano provato a utilizzare i classici coni a bordo campo, ma non funzionava, e allora ha optato per una soluzione pittoresca ma efficace, e non solo tatticamente. I Cheetahs erano considerati la franchigia “debole” del rugby sudafricano, non avevano tantissimi tifosi (tanto che Rassie e i giocatori giravano per strada per vendere i biglietti) e questa trovata fece tantissima pubblicità alla squadra, che cominciò a riempire lo stadio. All’ultimo Mondiale Erasmus ha ritirato fuori le luci da discoteca, stavolta portatili, per dare indicazioni ai suoi direttamente dalla tribuna. Inoltre, il soprannome DJ Rassie deriva anche da un’altra trovata: nel 2005 i Cheetahs raggiunsero la finale di Currie Cup, la più importante competizione sudafricana, e sognavano di tornare a vincerla dopo un digiuno che durava dal 1976. Bisognava però giocare al Loftus Versfeld di Pretoria, in casa dei Bulls, un catino rumorosissimo da 50mila spettatori: in Sudafrica, infatti, si è soliti mettere musica ad altissimo volume durante le fasi di stop della partita, quindi anche solo preparare una touche una mischia diventa complicatissimo se non si è abituati. Al vice di Erasmus, Franco Smith (che ha allenato tanti anni in Italia, al Benetton e in Nazionale) venne l’idea di far allenare i ragazzi sotto la stessa musica assordante: risultato? La prima volta vomitarono da quanto erano storditi. Poi però quella finale la vinsero, facendo un’impresa storica.
contro tutto e tutti
—
Quando Erasmus decise di tornare in Sudafrica dopo l’esperienza in Irlanda, trovò una polveriera. La squadra era demotivata e senza certezze, il movimento annaspava tra la necessità di ricostruirsi un’immagine e quella di non affondare definitivamente. E poi c’era il problema delle quote nere, da Erasmus sempre mal sopportate soprattutto per come venivano utilizzate. Uno dei motivi per cui aveva lasciato il Sudafrica era stato proprio aver visto i giocatori di colore umiliati, perché per rispettare le regole magari venivano messi in campo a pochi minuti dalla fine per fare numero o – ancora peggio – venivano schierati titolari e poi fatti uscire. Del resto lo stesso Siya Kolisi, primo capitano nero della storia del Sudafrica, disse “Mandela non avrebbe mai approvato le quote nere”. Proprio per evitare ulteriori polemiche a Erasmus fu consigliato di scegliere un capitano bianco “di transizione”. Ovviamente se ne fregò altamente e scelse subito Siya Kolisi, difendendo la sua scelta contro tutto e tutti. Il suo principio era talmente semplice da risultare quasi banale a chi non conosce la realtà di quel Sudafrica: non importa il colore della pelle, gioca chi merita. Mettere in campo 15 bianchi, 15 neri o metà e metà non cambiava assolutamente nulla. Da questa semplicità è nata la rivoluzione. Erasmus aveva anche un altro problema da risolvere: per quanto rugbisticamente rinomato, continuava a percepire quanto il Sudafrica venisse considerato un Paese del terzo mondo, anche a livello politico. Nel 2021 il Sudafrica arrivò alla serie coi Lions senza giocare dei test match per un anno e mezzo a causa del Covid, e non volevano nemmeno permettergli di disputare una sorta di amichevole col “Sudafrica A” proprio coi Lions a causa del rischio pandemico: andò dai dirigenti dei Lions e disse “Se la situazione è questa non giocheremo la serie”. Prese un rischio enorme, ma gli diedero ragione. Inoltre, dopo la prima partita della serie si rese conto che – a differenza dei Lions – il Sudafrica non aveva un accesso diretto al confronto con gli arbitri, una cosa tipica del rugby: si chiede il perché delle decisioni e ci si regola di conseguenza. Erasmus non riusciva in alcun modo a raggiungere l’australiano Nic Berry, e capì di dover fare una follia: caricò online un video di 62 minuti in cui discuteva tutte le decisioni del direttore di gara, inviandolo con un link privato a tutte le 9 persone del panel. Solo che una di queste – non si è mai capito chi – decise di renderlo pubblico, facendo scoppiare una polemica infinita: Erasmus fu accusato di voler destabilizzare gli arbitri (soprattutto dopo aver vinto quella serie) e di aver diffuso lui stesso il video. Del resto, la nomea non lo aiutava, visti i tantissimi tweet provocatori pubblicati contro gli arbitri nel corso degli anni: alcuni diretti, in cui contesta le decisioni arbitrali, altri più provocatori, pieni di frecciatine. Alla fine Erasmus è anche questo: prendere o lasciare.







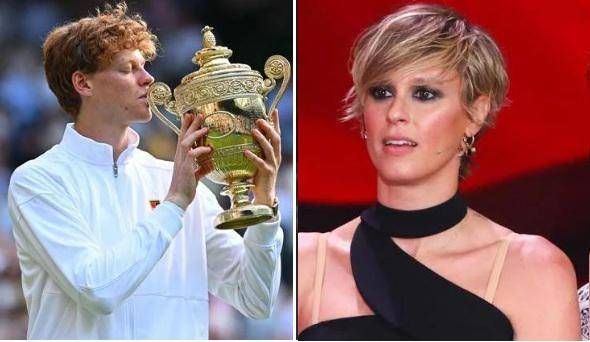




 English (US) ·
English (US) ·