Lo scrittore racconta il suo amore per il Napoli e lo sport: "Ero scarso in tutti gli sport. Diego è stato uno dono, mio padre svenne quando morì. Io allo stadio? Non è agevole, poi c’è la scaramanzia..."
C’è stato un tempo, spensierato e felice, in cui Roberto Saviano ha vissuto con la leggerezza dei bambini che inseguono gli aquiloni. E ci sono stati giorni, prima che Gomorra trasformasse le ore in tormento, ricchi di sogni che bisogna sognare. "Mentre adesso io sono solo la mia scrittura". C’è stato un bimbo e poi un fanciullo e poi un ragazzo che a quell’età voleva semplicemente essere un uomo, essere se stesso, non importa se pugile, cestista, calciatore o pallanotista o niente di tutto ciò: semplicemente libero di raccontarsi, persino sorridendo, su quello che poi non sarebbe stato, che non è stato.
Meno male per lo sport che Roberto Saviano ha capito in fretta che avrebbe dovuto scrivere...
"Diciamo che intuii presto di essere una vera schifezza in qualsiasi campo. E comunque agli inizi, qualunque fosse la disciplina nella quale mi mettevo alla prova, sembravo credibile".
Li incantava con le parole.
"Più o meno. Sapevo quasi tutto, che si parlasse di basket, di pallanuoto, di boxe. Arrivavo preparato: record, personaggi, storie. Poi mi mettevano alla prova e venivo smascherato. In realtà, sono stato un fallimento su questo piano".
Ha avuto maestri speciali: nel pugilato, ad esempio.
"Domenico Brillantino, non so se mi spiego, e nella sua Excelsior, palestra ricavata in una scuola dalla quale sono usciti campioni mondiali e olimpici. A Marcianise la nobile arte, come si diceva un tempo, venne praticamente importata dagli americani di stanza a Caserta durante la guerra: i soldati ingaggiavano, diciamo così, contadini del posto, investendoli del ruolo di avversari".

Bastarono poche riprese, a lei, Saviano, per svelarsi.
"Ma porto con me la profondità di Domenico Brillantino. Ne ho sempre parlato bene in giro e lui teneramente una volta mi disse: 'Non so perché lo fai'. Perché mi ha lasciato valori".
Scendiamo in acqua...
"Pallanotista senza un futuro. Però diventato amico di Estiarte, un genio che in carriera ha giocato anche per il Volturno. Ma io tiravo delle fetecchie che non prendevano mai la porta. Manuel sta dentro di me, un fuoriclasse di quello spessore con un senso della professionalità quasi inarrivabile".
Che un giorno le presenta Messi...
"Ero a Barcellona, vengo invitato al Camp Nou praticamente per testare un cubo di vetro dove poi sarebbe stato ospitato Obama, di lì a poco. Insomma, faccio quasi da cavia. E Manu mi fa conoscere Messi, che non so bene perché sia stato paragonato a Maradona. Lionel è enorme, ci mancherebbe, ma Diego è stato un dono concesso all’Argentina, a Napoli e in generale all’umanità".

Lei era bambino, quando El Pibe arrivò.
"E avevo 11 anni quando con l’Argentina vinse al San Paolo contro la Nazionale a Italia ‘90. Confesso che c’è stato un momento in cui ho tifato per lui, come tanti. A noi Diego ha regalato la possibilità di rivoluzionare il destino di tifosi, non avevamo mai vinto e lui ci ha aperto al successo. Lo abbiamo amato per il suo sguardo, con i suoi vizi, per la sua generosità e per quella quotidianità sotto assedio, sempre".
Il suo amore è stato e rimane il basket.
"Lo scudetto di Caserta, con la Phonola, uno dei momenti più toccanti. Una squadra di mostri, Shackleford in testa, il mio idolo, capace di dare l’equilibrio che i 50 punti di Oscar, negli anni precedenti, non riuscivano a garantire. Marcelletti, figlio ed erede di Tanjevic, riuscì a realizzare un’impresa, con un roster meraviglioso: Nando Gentile, Vincenzino Esposito, Dell’Agnello, ma tutti, proprio tutti da amare. Però Shackleford per me fu folgorazione: un giorno andai dal barbiere e gli chiesi di farmi i capelli come lui. Risposta realisticamente glaciale: è impossibile, Robé".

Lei era un playmaker, ovviamente.
"Un metro e settantatre. Non ero buono neanche per il basket. E la mia prima squadra, sembrerebbe ironia, si chiamava Clan...".
Dal campo di calcio la “espulse” suo padre.
"Si giocava anche per strada. Mi vide una volta e mi spinse a pensare ad altro. In compenso, mi ha trascinato allo stadio e viviamo ancora fusi nelle nostre visioni: le telefonate iniziano affettuosamente e proseguono sulle rispettive opinioni calcistiche. Penso emergerebbe pure in analisi da uno psicologo che tra di noi c’è un collegamento radicato attraverso il Napoli. Ho conosciuto Vinicio, Sivori, Burgnich, Juliano, Krol senza averli visti ma attraverso i suoi racconti. Lui che è svenuto quando è morto Diego".

Il Napoli allo stadio per ovvi motivi è impossibile.
"Mi piacerebbe, ci sarei potuto andare - non sarebbe stato agevole, chiaramente - ma a un certo punto, sa com’è la scaramanzia, ho preferito evitare. Vuoi vedere che perdiamo proprio nell’ora e mezza in cui ci sto io? mi sono detto".
Quattro scudetti non le bastano, par di capire.
"Voglio la stella. La merita De Laurentiis che, lo comprendo, lascia che la narrazione su di lui si fermi al manager calcistico, mentre gli va riconosciuto il merito di aver estirpato la camorra dallo stadio. La presenza della delinquenza nelle curve sta riemergendo adesso, con le varie inchieste che hanno mostrato l’omertà di alcune proprietà".
Il calciatore che la incanta oggi...
"Lobotka. È un intellettuale. Senza di lui, il calcio viene scarabocchiato".











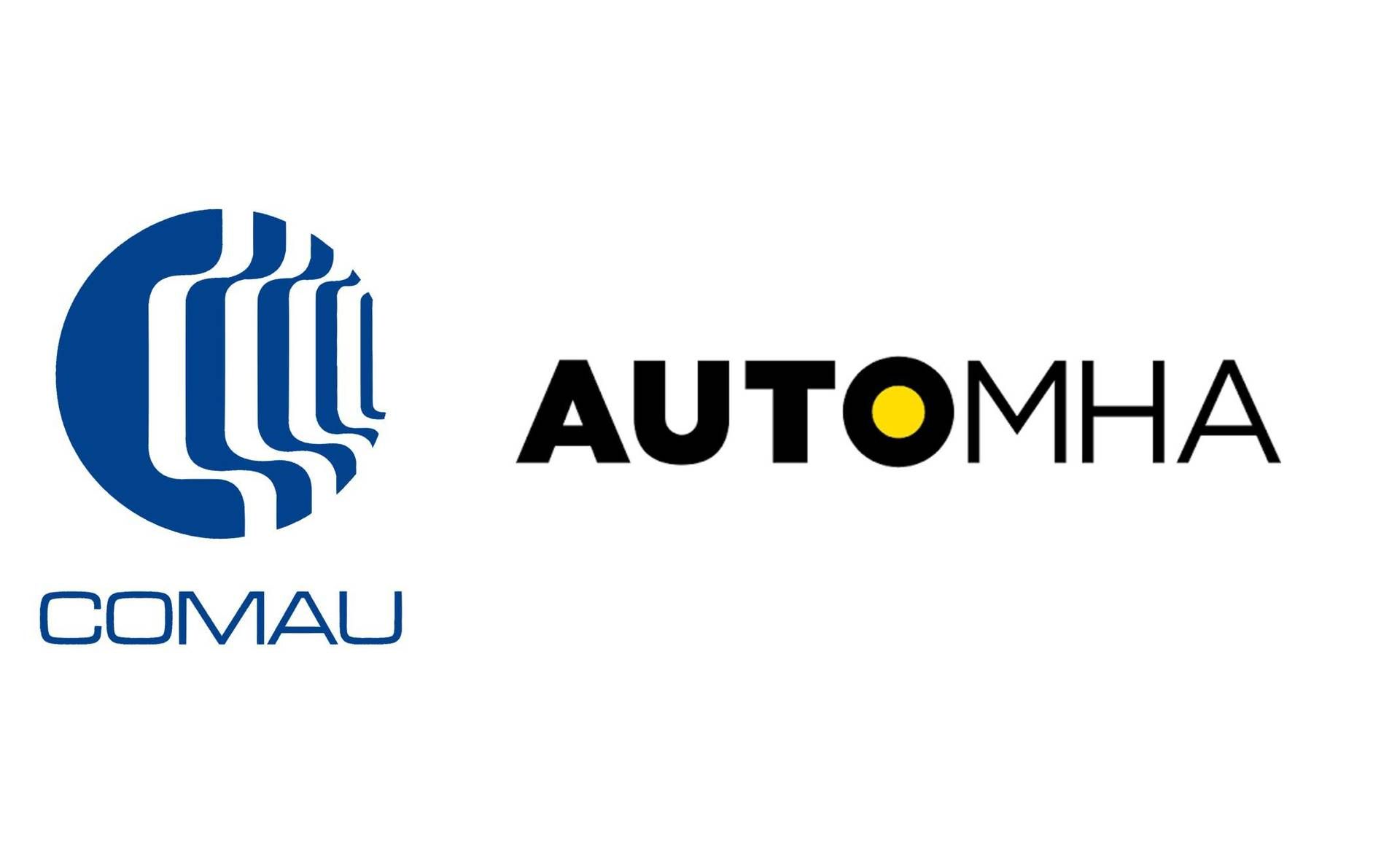

 English (US) ·
English (US) ·